Perils of Perception 2017: l'indagine sul pericolo delle percezioni
Perils of Perception di Ipsos compie 4 anni e amplia lo sguardo dai 14 Paesi (e quattro continenti) della prima edizione, che aveva incoronato l’Italia come Paese “più ignorante”, a 38 Paesi (in tutti i continenti), tra cui l’Italia spicca ancora nel terzo meno informato: il punto sulla distanza tra fatti e percezioni ci colloca infatti al 12° posto per quantità di errori, primi in Europa, dove invece i paesi Nordici – Danimarca, Norvegia e Svezia – brillano per capacità di stimare correttamente i fenomeni.
Visita il microsito
Quiz: Metti alla prova la conoscenza del tuo paese
Preme tuttavia sottolineare che, al di là degli scostamenti tra singoli Paesi e al di là degli errori casuali generati dalla tendenza a tirare ad indovinare su alcuni fatti, magari meno familiari all’opinione pubblica, si rileva una sistematica propensione a dipingere la realtà in modo peggiore di quanto non sia.
A livello di media globale, registriamo, ad esempio, che solo 7% dei quasi 30.000 cittadini intervistati ritengono che il tasso di omicidi nel loro Paese sia calato rispetto all’anno 2000, quando – per la gran parte dei Paesi – un decremento c’è stato, tant’è che in media, il calo registrato è pari al 29%. In Italia, ad esempio, il calo si attesta sul -39%, ma per un italiano su due la percezione è esattamente inversa, per uno su tre dal 2000 a oggi la situazione non è cambiata, ed è solo per un risicato 8% dei nostri concittadini che il fenomeno cala, così come davvero avviene.
E ancora: solo un intervistato su 5 (19%) stima correttamente che i morti per terrorismo sono calati – e non di poco – nei 15 anni trascorsi dall’attacco alle Torri Gemelle rispetto al quindicennio che ha preceduto. Anche per due terzi di italiani la situazione è peggiorata (31%) o, al più, è rimasta uguale (38%), quando invece si è passati da 60 a 4 dal primo al secondo periodo considerati.
Infine, la percezione della presenza di detenuti di origine straniera nelle carceri è percepita in media come il doppio di quella registrata ufficialmente (28% contro 15%). Anche in questo caso, gli Italiani non fanno eccezione, stimando che un ospite su due del nostro sistema penitenziario non sia nato in Italia, quando la realtà registra poco più di un terzo (48% vs. 34).
Ma perché si sbaglia? E perché si sbaglia così tanto? Alla base di questi errori di valutazione ci sono ragioni di vario genere, che possono andare dalla storica inimicizia tra gli italiani e l’aritmetica, fino alla tendenza ad utilizzare processi euristici quando si tratta di "pensare velocemente"
Una ragione su tutte potrebbe però, a nostro avviso, spiegare una buona parte di queste “esagerazioni” e cioè il fatto che tendiamo in modo naturale a sovrastimare tutto ciò che ci preoccupa, e tanto più quando questo tocca le nostre corde emotive e, a maggior ragione, quando la copertura mediatica è particolarmente intensa e sottolinea gli aspetti negativi e minacciosi di un fenomeno.
Il fatto di reagire a informazioni positive e negative in modo differente ha basi evolutive: per i nostri antenati dalla minaccia, dal rischio per la vita, arrivava un impulso all’azione: gli uomini – e le donne – delle caverne fuggivano o si attrezzavano al combattimento davanti alla tigre dai denti a sciabola. I più lenti furono darwinianamente eliminati…
Quindi, per quanto tempo sia trascorso, il nostro cervello è ancora abituato a trattare le informazioni positive e quelle negative in modo differente, e a tenere queste ultime in bella evidenza. Si sono moltiplicate le ricerche scientifiche su questo tema, che hanno dimostrato che eventi come perdere del danaro, essere lasciati, o ricevere osservazioni critiche hanno tutti maggior impatto emotivo che non vincere una somma, fare nuove amicizie, o ricevere complimenti.
A questo proposito, illuminante è il lavoro dello psicologo e neuroscienziato John T. Cacioppo, professore alla Ohio State, che ha dimostrato che l’incremento di attività elettrica nel cervello prodotto dalla visione di immagini a forte contenuto negativo – nell’esperimento: un viso sfigurato, un gatto morto – è molto più elevata di quando non si contempla una foto che raffigura un’invitante fetta di pizza o una splendida fuoriserie. Studi ancora più approfonditi hanno dimostrato inoltre che il cervello utilizza maggiore intensità di energia e aree diverse per elaborare le immagini negative, piuttosto che quelle positive.
Può sembrare incredibile, ma se le brutte notizie catturano l’attenzione con grande rapidità, quelle belle necessitano di tempo per sedimentare, in un processo graduale e incrementale. Come fa notare Max Roser della Oxford University, i giornali avrebbero potuto legittimamente titolare “Il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema è calato di 137.000 unità da ieri a oggi” ogni giorno, per gli ultimi 25 anni. Ma si tratta di una non-notizia, e si tratta di materiale che noi, come consumatori di notizie, non cerchiamo.
Un esempio italiano: è abbastanza semplice trovare titoli che puntano i riflettori sull’ “emergenza” della violenza sui bambini da parte delle maestre nelle scuole dell’infanzia, seguiti invariabilmente dall’appello ad installare telecamere in tutti gli asili della penisola per vigilare sul benessere psicofisico dei piccoli. Ovviamente, e sfortunatamente, i giornali non pullulano invece di foto e filmati di maestre allegre e affettuose che si occupano delle loro classi felici con titoli come “E anche oggi, in questa classe è stata una magnifica giornata e i bambini hanno imparato una nuova tecnica di pittura!”
Uno spunto di segno opposto per il dibattito su questo tema arriva dalla proposta di una visione più ottimista: Matt Ridley con il suo Un ottimista razionale, o Johan Norberg in Progress. Ten Reasons to Look Forward, contrappongono alla visione catastrofista prediletta dai più – e dai media in special modo –, una lettura più rosea, che sottolinea come i grandi problemi che hanno afflitto in passato l’umanità siano in realtà in fase di risoluzione e che pertanto possiamo guardare avanti con speranza.
Vero. Ma forse ciò che questi autori non esplicitano, è che questo ottimismo deve nutrirsi di fatti e di azioni che, al momento, sembrano latitare: un esempio per tutti, l’adesione globale al protocollo di Kioto/Doha verso una soluzione al degrado ambientale. Con quale ottimismo possiamo guardare al futuro della terra, se gli USA, che contribuiscono per un terzo alle emissioni di biossido di carbonio, si rifiutano di ratificare il protocollo?
Di fatto, le tendenze che registriamo nella percezione dei fenomeni sociali, indicano una sorta di rassegnazione al peggio, almeno a livello percettivo. Una rassegnazione che ha a che fare, tra le altre cose, con la portata degli eventi con cui veniamo in contatto, che ci sembrano fuori scala rispetto alle nostre possibilità di intervento. Lo dimostra bene il professor Slovic, che conia la definizione di “insensibilità psichica” (Psychic Numbing) che, ad esempio spiega l’enormità della reazione emotiva dell’opinione pubblica davanti alla morte del piccolo Aylan Kurdi, nel settembre di due anni fa. E che, in realtà, rappresentava soltanto l’ennesimo caso di un’ecatombe che, al tempo, aveva già provocato 250.000 morti nella popolazione della Siria.
Questo stesso effetto, che ci rende insensibili davanti a un vero genocidio, è lo stesso che influenza la nostra capacità a credere che le grandi sfide sociali possano in qualche modo essere affrontate e risolte.
E quindi, forse, la soluzione non va cercata tanto nell’invito a pensare positivo, quanto invece nell’ideare iniziative che possano contrastare l’idea che tutto sia ormai perduto.
Note tecniche
Questi sono i risultati dell’indagine IPSOS Perils of Perception 2017. Sono state condotte 29,133 interviste tra il 28 settembre e il 19 ottobre 2017. Lo studio è stato condotto in 38 paesi nel mondo attraverso gli Ipsos Online Panel in Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Peru, Polonia, Russia, Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, e USA. Nei seguenti paesi l’indagine è stata condotta online o face to face : Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia e Serbia. Sono stati intervistati circa 1.000 individui tra 16 e 64 anni o tra 18 e 64 anni in ciascuno dei seguenti paesi: Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Gran Bretagna, Hong Kong, Indonesia, Italia, Giappone, Montenegro, Norvegia, Russia, Serbia, Spagna, e USA. In Germania l’ampiezza del campione era pari a 2.000 individui e nei Paesi Bassi circa 900 rispondenti, in entrambi I casi di età compresa tra 16 e 64 anni. Negli altri Paesi: Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Cile, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Ungheria, India, Israele, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Peru, Filippine, Polonia, Singapore, Sudafrica, Svezia, Turchia, sono stati intervistati 500 individui tra 16 e 64 anni. I dati reali di riferimento per ciascuna domanda sono stati tratti da differenti fonti ufficiali e/o verificate. La lista completa delle fonti può essere consultata qui http://perils.ipsos.com/ Nei casi in cui i risultati non sommano a 100 oppure nei casi in cui la differenza è di ±1 del reale, la causa può essere ricondotta agli arrotondamenti, alla presenza di risposte multiple oppure alla mancata inclusione delle risposte “non sa” o delle mancate risposte. I dati sono ponderati per ripristinare la corretta profilazione della popolazione di ciascun Paese.
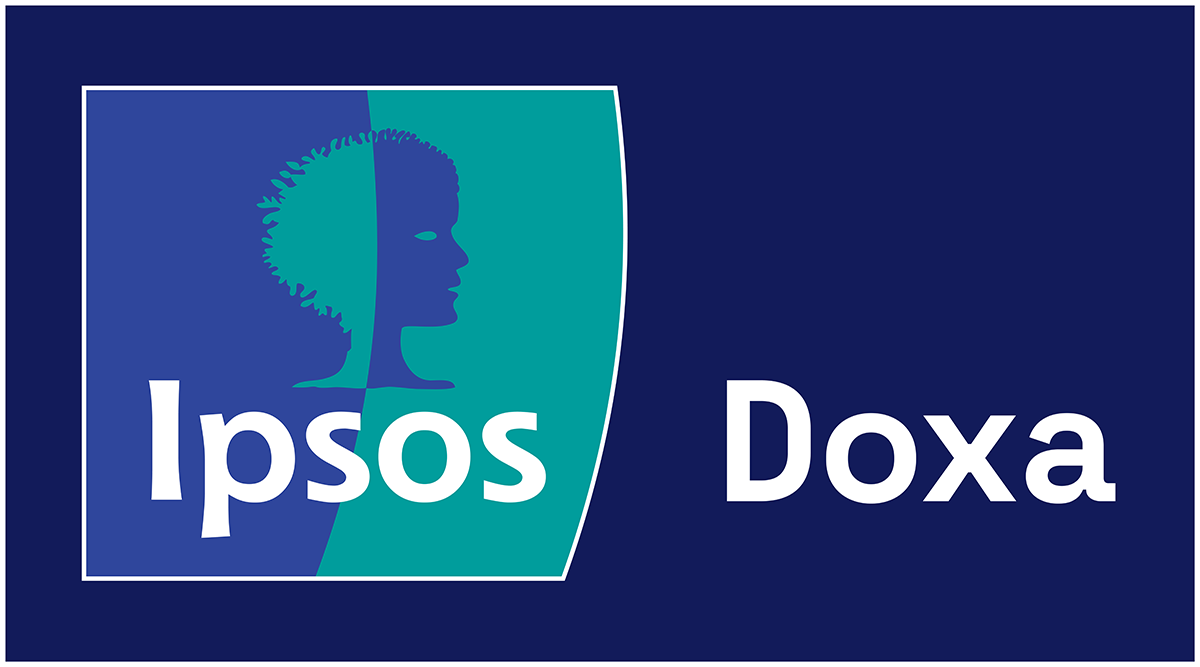
![[EVENTO] Ipsos presenta Flair Italia 2023](/sites/default/files/styles/list_item_image/public/ct/event/2023-04/evento-ipsos-flair-italia-2023%20%282%29.png?itok=0L9PKcej)
![[WEBINAR] KnowledgePanel®: l'unico panel probabilistico in Italia](/sites/default/files/styles/list_item_image/public/ct/event/2023-03/webinar-knowledgepanel%C2%AE-unico-panel-probabilistico-italia.png?itok=zM4j-xt8)
![[EVENTO] Wired Trends 2023: visioni sull'anno che verrà](/sites/default/files/styles/list_item_image/public/ct/event/2022-11/evento-wired-trends-2023-visioni-anno-che-verra.png?itok=I9Hbgsft)