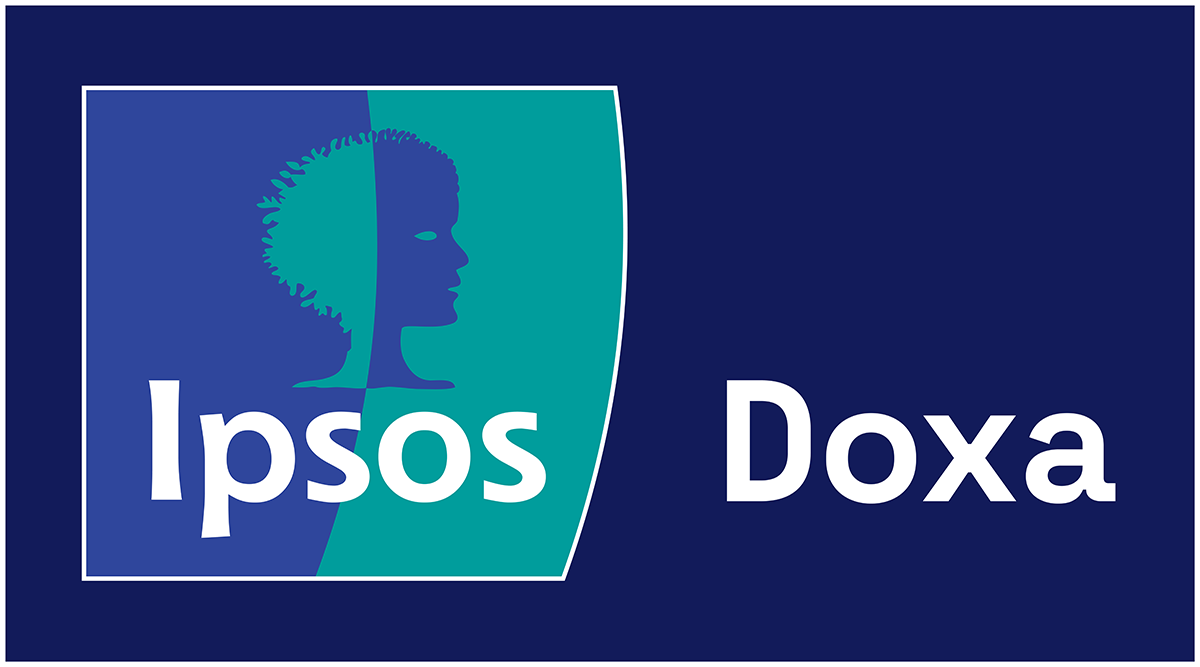23 maggio, 31 anni dalla strage di Capaci: le opinioni sul fenomeno mafioso in Italia
Il 23 maggio 1992 durante la strage -notoriamente conosciuta come strage di Capaci- il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro persero la vita in un attentato organizzato da Cosa Nostra nei pressi di Capaci, in Sicilia.
La strage di Capaci, insieme a quella di via d’Amelio del 19 luglio, è considerata il momento simbolicamente più rappresentativo dello scontro tra Cosa Nostra, la mafia siciliana, e lo Stato italiano. Ad oltre trent’anni da quel momento, quali sono le opinioni degli italiani sul fenomeno mafioso in Italia e sul suo cambiamento nel tempo? Lo scopriamo nell'ultimo sondaggio d'opinione Ipsos, a cura del team di Public Affairs, realizzato in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci.
23 maggio 1992, la strage di Capaci e l'uccisione di Giovanni Falcone
La strage di Capaci fu un attentato compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci, in Sicilia, organizzato per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29 mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di Polizia. Durante la tragica strage morirono cinque persone: Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo -anche lei magistrato- e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro e vi furono 23 feriti.
31 anni dopo la strage di Capaci, il cambiamento della mafia nel mondo di oggi
Dopo aver contribuito alla celebrazione del trentennale della strage l’anno scorso a Palermo, su invito della Fondazione Falcone con un’indagine demoscopica apposita, il team Public Affairs di Ipsos ha continuato a monitorare opinioni e attitudini sul tema. I risultati dell'ultimo sondaggio, realizzato in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci, forniscono due principali spunti di riflessione.
Da un lato, è evidente come il cambiamento del fenomeno mafioso in Italia sia stato colto negli anni dalle persone nel nostro Paese: la mafia del 2023 non è più quella del passato, questo è sostenuto da un’ampia maggioranza. Quasi quattro italiani su cinque (il 77%) condividono l’opinione per cui “i mafiosi di oggi non sono più contadini semianalfabeti, ma manager in giacca e cravatta che girano il mondo”.
Inoltre, che le mafie non siano più un fenomeno circoscritto alle regioni del Mezzogiorno, ma che si siano diffuse anche nel resto d’Italia e del mondo, lo pensano tre su quattro. Il 71% ritiene anche che, più che armi e violenza, siano oggi la finanza globale e le grandi multinazionali l’ambito d’azione prediletto dei mafiosi.
Si conferma, quindi, il tramonto di una lettura “culturale” del fenomeno mafioso: che la mafia sia “un fenomeno culturale, una mentalità insita in alcune fasce della popolazione” lo ritiene soltanto un italiano su sei. Si tratta piuttosto di una degenerazione criminale di forme di potere economico (per il 19%) o politico (per il 20%) o, ancor più semplicemente, di una manifestazione estremamente violenta e organizzata di criminalità (opinione prevalente con il 28%).
La priorità del problema mafioso in Italia
Dall’altro lato preoccupa, tuttavia, il calo tendenziale di priorità attribuita al problema mafioso che registriamo a distanza di un anno: a considerare quello delle mafie “il problema più urgente” o “uno dei problemi più urgenti” per l’Italia è ancora una maggioranza (il 55%), ma il dato segna un calo di ben 7 punti rispetto al 2022. Se si declina la domanda sul Mezzogiorno la percentuale attuale è del 61%, ma il calo è addirittura di 8 punti rispetto ad un anno fa.
Ancora: l’importanza di parlare di antimafia nelle scuole appare anch’essa in calo, confermando un trend già registrato a marzo in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A ritenere “fondamentale” o “abbastanza importante” che a scuola si parli dei temi legati alla lotta alle mafie è oggi il 71%, a marzo il dato si attestava al 76% e un anno fa al 79%.
L'importanza della cultura della legalità
La percezione della gravità del fenomeno mafioso è ancora molto alta e i sondaggi mostrano una grande consapevolezza della necessità di perseverare nella lotta, anche culturale ed educativa, al fenomeno mafioso. Il mutamento di pelle delle mafie italiane e la loro adozione di modus operandi meno appariscenti dal punto di vista della violenza armata –ben percepiti dalla popolazione– stanno però forse lentamente allentando la percezione del pericolo e attenuando la priorità attribuita al problema.
L’importanza di coltivare la cultura dell’antimafia è riconosciuta ampiamente, ma forse quest’ultima deve seguire più da vicino questo mutamento e affiancare agli indispensabili momenti di commemorazione elementi di approfondimento che facciano comprendere come le mafie, anche se abbandonano la loro dimensione tradizionale per assumerne una globale passando “dalla lupara alla finanza internazionale”, rimangano pericolose come e più di prima.